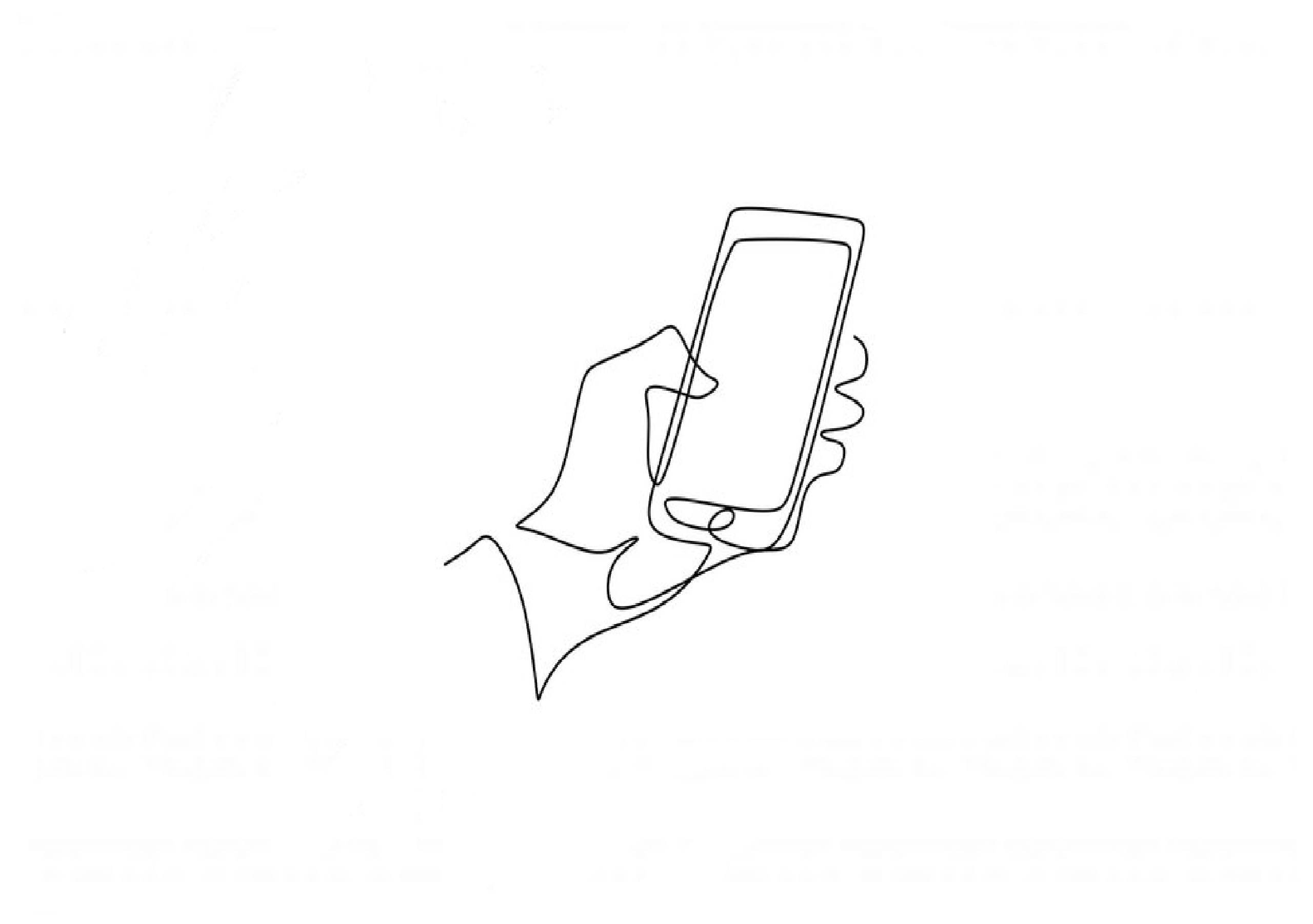Alcuni incresciosi fatti di cronaca hanno infatti riposto al centro del dibattito pubblico l’hate speech, le sue varie forme, le sue molte drammatiche conseguenze sugli individui e sulla società. È un bene che sia così, e che ci si interroghi su quanto i discorsi d’odio possano facilmente propagarsi, ferire le persone, inquinare gli spazi pubblici e privati, che nei social media diventano un tutt’uno. Ed è un bene che si chieda – a tutt*, non solo alle persone direttamente coinvolte – più attenzione, consapevolezza, responsabilità.
Ma è anche allarmante e disarmante che, ogni volta, dopo tanti anni di ragionamenti, di lavori, e di iniziative per arginare i discorsi d’odio siamo ancora lì a parlarne come se fosse sempre la prima volta. Come se da tempo non stessimo assistendo al consolidamento di fenomeni che fanno orami parte da tempo del nostro quotidiano interagire attraverso i social media.
Da tempo sappiamo tutto, o quasi, delle gogne mediatiche (che pre-datano la comunicazione nei social: si pensi soltanto agli anni di “Mani pulite”) ma che grazie ai social media sono diventate quotidiane, non mediate, spesso deresponsabilizzate perché prodotte da una moltitudine. Sappiamo che esercitare una gogna collettiva verso una persona che neppure si conosce può far sedimentare ostilità dispersa e aggressività diffusa. Che con la gogna non si cerca né ‘verità’ né ‘giustizia’, ma solo l’opportunità di poter odiare un soggetto senza riserve e senza il pericolo di subire reprimende. E che così l’odio diventa un elemento che unisce, una valvola di sfogo comune che crea solidarietà tra chi attacca, ed estrema marginalizzazione e solitudine in chi viene attaccat*.
Siamo anche oltre la ‘gogna mediatica’. Siamo a circoli viziosi di hate speech che si generano in un catene di botta e risposta senza nessun* che faccia mai un passo indietro, chieda scusa, dica “mi sono sbagliat*”, si prenda il tempo per riflettere sulle proprie abitudini prima di partire lancia in resta contro qualcosa o qualcun*, ergendosi contemporaneamente a pubblica accusa e giudice, e di fatto vanificando ogni possibile meccanismo di difesa.
Siamo in una nuova era della comunicazione, in cui tutto ciò che scriviamo può diventare pubblico e può essere usato contro di noi: dove gli effetti prevalgono sulle intenzioni, dove i codici culturali cambiano rapidamente – più di quanto ce ne accorgiamo – e ogni messaggio può essere frainteso distorto o manipolato, avere infinite interpretazioni, offendere la sensibilità di qualcun*, dove si mettono in gioco non solo competenze linguistiche e relazionali, ma anche la reputazione nostra e delle altre persone. Dove il silenzio viene visto come una resa.
Che fare, allora?
Osservare con attenzione l’evoluzione dei fenomeni, non solo quando diventano fatto del giorno, ma costantemente, richiede metodo, risorse, lavoro in network tra utenti, soggetti della società civile, target di discorsi d’odio, media, piattaforme digitali, policy maker. Richiede un continuo investimento in formazione ed educazione, per rendere tutt* più consapevoli circa le sfide e i rischi del comunicare in rete, le competenze minime necessarie per poterlo fare, e i diritti e doveri di ciascun*. Richiede norme certe e soprattutto politiche di ampio respiro per una literacy digitale, e per fornire supporto e servizi alle persone colpite da discorsi e crimini d’odio. Richiede grande attenzione e responsabilità da parte di chi fa informazione: nell’evitare tanto di inseguire non-notizie per ragioni di clickbait, andando dietro agli umori ondivaghi della rete, quanto di trattare i discorsi d’odio superficialmente, attraverso scorciatoie moralistiche, autoassoluzioni, ricerca di facili capri espiatori (“è tutta colpa dei social media”).
Come Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio vorremmo perciò vedere finalmente un giornalismo deontologicamente maturo quando si parla di hate speech, capace di tenere in considerazione le complessità, le dinamiche, e tutti i soggetti coinvolti.
Vorremmo vedere maggiore responsabilità e consapevolezza da parte di tutta l’utenza. Che deve sapere quanti e quali effetti gli shitstorm a cui si partecipa, spesso senza battere ciglio, possono avere sulle persone a cui questi sono indirizzati, e sulle loro famiglie.
Vorremmo, infine, non dover mai assistere all’uso di discorsi odio in risposta all’odio. L’ ‘odio dei giusti’ non è migliore di quello di hater e ‘centrali dell’odio’. Anzi, l’ ‘odio dei giusti’ non esiste: perché esiste solo il discorso d’odio – che non è mai ‘giusto’ – con le sue devastanti conseguenze.
Conosciamo piuttosto bene, ormai, l’hate speech, le sue definizioni, le sue forme, la sua portata sulle ‘vittime’, dirette e indirette. Ma moltissimo resta da fare nella nostra pratica quotidiana per arrestare il circolo vizioso di shitstorm, aggressività compulsiva, messa in gogna, deresponsabilizzazione individuale e collettiva. E moltissimo si deve e si può fare per chiedere e ottenere risorse adeguate per fare formazione, educazione, prevenzione: a tutti i livelli, per tutte le fasce di utenza e di età, con continuità e una visione di lunga durata che possa incidere anche sulle cause.
Perché con le risposte soltanto emotive – che spesso durano lo spazio di un mattino, sull’onda dell’ennesimo fatto di cronaca – non se ne viene a capo. Anche se sarebbe facile, e tutto sommato comodo, volerlo credere.
Coordinamento della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio